
Il ricordo di Mons. Franco Giulio Brambilla nella presentazione della seconda edizione del manuale di “Pedagogia pastorale – Questa sconosciuta” dell’amico fraterno don Antonio Fallico. Era il 2010 quando l’allora Vescovo ausiliare di Milano, presentando il manuale del pastoralista catanese, diceva: “questo è in qualche modo la summa del suo modo di intendere la missione ecclesiale. Essa è come il momento di autocoscienza della sua insonne passione di ripensare la pastorale nel legame tra Chiesa e Mondo. Quest’opera andrebbe collocata sullo sfondo del suo progetto di fare della Chiesa locale, in particolare della parrocchia, una “comunione di comunità”.
Di seguito si riporta il commento di Mons. Brambilla:
Il termine “pastorale” è stato il leitmotiv del Concilio Vaticano II. Nel post-concilio è diventato quasi una parola “magica” che ha corso il pericolo dell’inflazione. Tutto è diventato pastorale e ogni cosa doveva essere pastorale. Il motivo della fortuna del termine, che fu assunto per indicare lo spirito del Concilio, risale allo stesso Papa Giovanni che con tale espressione volle indicare l’intenzione sintetica proposta all’assise mondiale del Vescovi. Già dal suo annuncio, il Papa enfatizzò l’intento pastorale del Concilio, che egli declinava in tre aspetti: l’apertura della Chiesa al mondo moderno, la ricomposizione dell’unità tra i cristiani e il tema della giustizia e della pace. Fin dal gennaio del 1959 queste istanze parvero subito tratteggiate e troveranno nel discorso di apertura del Concilio la loro convinta proclamazione. Il testo della Gaudet Mater Ecclesia, diventato giustamente famoso, indicava lo stile del Concilio nella sfida ai “profeti di sventura”: «essi non sono capaci di veder altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori; e arrivano al punto da comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia, che è maestra di vita, e come se ai tempi dei precedenti Concili tutto procedesse felicemente quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla giusta libertà della Chiesa». E di seguito il Papa aggiunge con uno scatto di speranza: «A noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura, che annunciano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo».
In realtà, non sta qui la vera novità del discorso di apertura al Concilio. Potremmo dire che questo è l’elemento atmosferico, il motivo che apre la stagione della “primavera” della Chiesa. Più decisivo sarà l’altro passaggio che spiega l’intento “pastorale” del Concilio. Ascoltiamolo: «Per intavolare simili discussioni non era necessario indire un Concilio Ecumenico. Al presente bisogna invece che in questi nostri tempi l’intero insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo esame […]; occorre che questa dottrina certa e immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita e esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altra è la sostanza dell’antica dottrina del depositum fidei, ed altra è la formulazione del suo rivestimento: ed è di questo che devesi – con pazienza se occorre – tener gran conto, tutto misurando nelle forme e proporzioni di un magistero a carattere prevalentemente pastorale» (sott. nostra; così il testo apparso in Osservatore Romano).
A questo proposito esiste anche un piccolo giallo. Il testo latino ufficiale apparso negli Acta Apostolicae Sedis “correggeva” il discorso di mano dello stesso Pontefice. Recita infatti: Est enim aliud ipsum depositum fidei, seu veritates, quae veneranda nostra doctrina continentur, aliud modus, quo eaedem enuntiantur, eodem tamen sensu eademque sententia. Per questo oggi leggiamo nell’Enchiridium Vaticanum la traduzione sul testo latino rivisto: «Altro è infatti il deposito della fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina; altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione» (EV I, 55*). Ma Papa Giovanni continuò a citare con candido puntiglio, anche dopo la “traduzione ufficiale” latina (ad es. ai cardinali, il 23 dicembre 1962), la sua scrittura italiana del testo. La diversità – come si può vedere – non è di poco conto per spiegare il senso dell’“indole pastorale” del Concilio. Il Pontefice distingueva, nell’antica dottrina del depositum fidei, la “sostanza” dal “rivestimento”, identificando il programma di “aggiornamento” in un “magistero a carattere prevalentemente pastorale”. Mentre la correzione dell’invisibile mano latina riportava la questione a una concezione “dottrinalista” della rivelazione, parlando del depositum fidei come di un insieme di veritates (si noti il plurale!), di cui possono esistere modalità diverse di formulazione. Papa Giovanni richiamava la coppia “sostanza”-“rivestimento” probabilmente secondo il senso comune, mentre la correzione latina riproponeva la distinzione tra verità dottrinale e formulazione linguistica. Se al Papa si fosse chiesto in che cosa consistesse la sostanza del messaggio cristiano, certo avrebbe risposto, con il linguaggio di quel tempo, l’incarnazione del Verbo, la stessa persona di Gesù Cristo. Fin qui l’intuizione ancora aurorale del Papa.
Tuttavia, come ha fatto notare uno dei commentatori del Concilio, non si può sfilare il “rivestimento” dalla “sostanza” della fede, con la stessa disinvoltura con cui le bambine vestono e svestono la loro Barbie (Schillebeeckx). Qui nasce il conflitto delle interpretazioni circa il senso del carattere “pastorale” dei pronunciamenti conciliari, ma soprattutto prende avvio il grande lavoro del Concilio per riformulare i temi della rivelazione, della chiesa e del mondo. Amo pensare che la proposizione di papa Giovanni sia più utile per dire che cosa va superato (una concezione esclusivamente dottrinale della rivelazione), che per suggerire come deve essere pensato in positivo il rapporto tra sostanza e rivestimento. La formulazione è ancora maldestra e troverà solo alla fine del Concilio un suo assestamento nella coppia, di ascendenza francese, di rivelazione “evento” e “parola”. Con una chiara prevalenza della “rivelazione-evento”, abbandonando talvolta la “rivelazione-parola” al ruolo di mero “rivestimento” culturale dell’ineffabilità dell’evento. L’oscillazione del pendolo è evidente: da una concezione dottrinalista a una concezione eventistica della rivelazione. Se il merito dell’intervento del Pontefice era di sdoganare il messaggio cristiano e il suo annuncio nel mondo contemporaneo da una visione concettualista della verità cristiana, il pericolo del postconcilio sarà di risospingere il cuore della fede in una zona di ineffabilità, che avrebbe poi dovuto indossare la “veste” di una parola da adattare sempre da capo al linguaggio del tempo, in una sorta di… interpretazione infinita. Era questo il senso del magistero “pastorale”? Si riduceva solo a un problema di comunicabilità e comunicazione? O andava forse a toccare più in profondità il senso della verità cristiana?
Sta di fatto che dopo il Concilio il termine “pastorale” dilaga. Non è stato il Concilio a inventarlo, è stata forse la spinta del Concilio a democratizzarlo. Esso non indica solo un problema di metodo: dire la fede di sempre nelle forme nuove della cultura, appunto il programma conciliare di “aggiornamento”. Suggerisce anche una questione di contenuto: riguarda la missione della Chiesa. Vale a dire, il fatto che l’agire storico della Chiesa, appunto la sua “missione pastorale”, non riveste più la figura dell’applicazione di verità immutabili sapute a monte delle forme pratiche con cui la Chiesa edifica se stessa nel mondo contemporaneo. La forma pratica non deduce semplicemente una verità già conosciuta a prescindere dal suo darsi nella storia, ma la sua realizzazione contribuisce al sapere stesso della verità cristiana. La storia non è un optional per l’agire della Chiesa, il semplice rispecchiamento di una verità eterna. Si può farlo intuire anche in termini abbastanza semplici: fino al Concilio (e oltre), un sacerdote, dotato del bagaglio della dogmatica e della morale e con la guida del diritto canonico (universale e locale), era abilitato alla pratica di un ministero che risultava sovente fruttuoso e fecondo. Ne è sicura testimonianza questo fatto: gli esami necessari per accedere al ministero comportavano di aver compiuto i corsi di teologia, dove regnava la dogmatica, e un esame di abilitazione al ministero (uno strano mix di morale e diritto, prevalentemente legato all’ordinamento sacramentale). Per quanto riguardava l’esperienza pastorale ci si affidava a qualche volonteroso tirocinio, che avrebbe dovuto rendere abile il pastore a quella forma singolare di sapienza che è la cura animarum. Per i più “esperti” un’abilitazione condita da un forte senso di spiritualità. Per il resto era la stessa vita “apostolica” – così si diceva allora – a scolpire i tratti del pastore. Sembra però una strana coincidenza della storia: mentre si metteva in discussione una visione dottrinalista della rivelazione e della fede, nello stesso tempo e nella stessa area culturale (la Francia tra le due guerre mondiali del Novecento) ci s’accorgeva della drammatica irrilevanza della “missione” della Chiesa nel mondo contemporaneo. Si deve dire che questo clima è l’atmosfera che ha prodotto le istanze di rinnovamento del Concilio. Non è un caso che i due Papi che l’hanno voluto e portato a termine ne abbiano subìto l’influsso.
Problema di metodo e questione di contenuto sembravano, dunque, cospirare insieme. In termini alti si potrebbe parlare dell’ingresso della “storia” nella teologia e nella missione della Chiesa. Alla radice di questo ritardo sta una ragione profonda e un motivo prossimo. La ragione profonda risale molto tempo addietro alla separazione moderna di ragione e fede. Da questa separazione fondamentale derivano le successive dicotomie: la divisione fondamentale avviene tra la ragione e la fede e configura l’esperienza della vita e la forma del pensiero animato dal credere come successivo a un sentimento dell’esistenza che per l’essenziale appare praticabile e sensato prima e a prescindere dalla fede. E alla fede eventualmente ricorre quando sperimenta il limite del sapere razionale di fronte al fallimento e alla morte. L’eccedenza della fede appare sopraggiungere in seconda battuta, la sua funzione redentiva arriva sempre troppo tardi, sospingendo il credere ai margini di una vita, sempre più dominata dalla ragione e dalla figura travolgente del sapere sperimentale. Questo “sentire” fondamentale produce nella modernità le altre fratture: la separazione drammatica tra teologia e spiritualità e tra sapere teorico e forma pratica della vita. Soprattutto la separazione tra teoria e prassi, che ha il suo riflesso in teologia nella divisione di dogmatica e morale, consegna la dogmatica alla sua forma dottrinalista, svuotandone la forza vitale, e rinchiude la scienza morale nella sua forma “casuistica” che ha avuto dopo Trento una lussureggiante produzione, legata al ministero del confessore. La figura del pratico nella vita cristiana perde il contatto vivo con la dogmatica e la spiritualità, e si estenua in un’interminabile ricerca del compromesso per rendere persuasiva l’esistenza cristiana. Il pratico assume un profilo “deduttivo” ed “esecutivo”: deve applicare i principi o i valori alla vita, deve rendere possibile l’universale nella molteplicità irriducibile del concreto. Perché in ogni caso la vita è in singulari. Di queste separazioni, l’ultima in ordine di emergenza, ma non certo ininfluente per la missione della Chiesa è quella tra teologia e pastorale, tra sapere della fede e pratica del ministero ecclesiale.
Di qui scaturisce il motivo prossimo: la figura più diffusa del rapporto tra teologia e pastorale è stata prevalentemente “applicativa”: la dogmatica, la morale e la spiritualità stabilivano la costellazione valoriale per la missione della Chiesa; eventualmente il diritto ne determinava la grammatica fondamentale; la pastorale non era che il luogo di “attuazione” mediante l’agire storico della Chiesa. E nel sistema della teologia di scuola e del regime di cristianità – lo dicevamo poc’anzi riferendoci alla formazione del sacerdote – ciò è sembrato persino funzionare bene. Quando però nel momento successivo al Concilio (con avvisaglie molto forti già a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale) questo contesto si è frantumato, l’immagine “applicativa” della pastorale è andata rapidamente in crisi e con essa la funzione “direttiva” del ministero pastorale. Si è aperto nell’agire storico della chiesa, cioè nelle forme della sua missione, un ampio spazio di “opzionalità”, di “discernimento” del funzionamento sociale dell’azione pastorale della chiesa. “Opzionalità” non significa però subito arbitrarietà, anche se talvolta la pratica concreta ha dato l’impressione di deflagrare in una galassia di interventi tanto volenterosi quanto divergenti nell’effetto pratico. Di qui le parole d’ordine della pastorale del postconcilio: “discernimento comunitario”, “conversione missionaria”, “pastorale integrata”, “nuova evangelizzazione”. Tutte etichette volte a segnalare il mutamento dello stile dell’agire pastorale della Chiesa. Esso riguarda sia il soggetto e il fine dell’agire della Chiesa (il passaggio dalla cura animarum incentrata sulla figura del pastore alla edificazione della Chiesa da parte di tutto popolo di Dio), sia la forma e il modo della sua missione nel mondo (che passa da un procedimento deduttivo alla figura del discernimento ecclesiale).
Per quanto riguarda il soggetto e il fine, il contributo del Concilio è stato determinante ed è presto detto. La sua ecclesiologia, che riporta in onore la categoria di “popolo di Dio”, fa compiere un passo in avanti nella comprensione dell’azione “pastorale”. Il passaggio che sta avvenendo è determinato dal mutamento dell’immagine di chiesa. Un trapasso che non deriva solo dal “mondo che cambia”, ma anche dalla ripresa della coscienza ecclesiologica del Vaticano II, che risale all’immagine della Chiesa degli Apostoli e alla pratica eucaristica delle Chiese locali del primo millennio. Fino al Concilio, “pastorale” significava anzitutto l’azione del pastore (del parroco principalmente) per cura delle anime, nell’ottica della salus animarum. Ciò aveva a che fare anche con una certa concezione del cristianesimo, incentrato sulla questione della salvezza individuale ed eterna. Il limite fondamentale di questa immagine sta nella concezione “verticale” e “individualistica” del rapporto del pastore con la guida pastorale, definita con il plurale di cura delle “anime”. Si prestava meno attenzione alla formazione di una comunità fraterna. Sul versante della comprensione di sé del prete, questa immagine comportava di pensare il ministero più come soggetto di rapporti direttivi e unidirezionali con le “anime”, che come membro di un presbiterio (e di una comunità) con cui condividere la missione. Tale figura del pastore/parroco ha sostenuto storie splendide di santità. Qui però non è in discussione l’autenticità personale del prete, bensì l’immagine ecclesiologica del ministero.
L’ecclesiologia del Vaticano II procede oltre o, se si vuole, torna alle origini. Essa afferma che l’azione pastorale ha come obiettivo l’edificazione della Chiesa come segno reale del Vangelo accolto per la vita del mondo. Si noti la formula calcolata: l’agire della chiesa ha come scopo non solo la cura delle anime (anche!), ma soprattutto l’edificazione della comunità. Ha una prospettiva eminentemente ecclesiologica. Fare la chiesa è di più della cura delle singole anime, a quel modo che la communio non è la semplice somma della storia dei suoi membri. Comprende certo la vicenda spirituale delle persone, ma la forma storica della Chiesa è di più. È il popolo santo di Dio nel tempo. Per questo l’agire pastorale non ha un orizzonte ecclesiocentrico. Che significa, infatti, edificare la Chiesa? Essere e fare la Chiesa – dicevamo – significa essere “segno reale” del vangelo accolto per la vita del mondo! Solo pensando e vivendo la Chiesa in prospettiva cristologica (il Vangelo di Gesù accolto) e in un orizzonte missionario (per la vita del mondo), la “pastorale” viene sottratta al suo ripiegamento autoreferenziale. Allora, l’agire pastorale non ha più come soggetto solo il pastore e i “collaboratori dell’apostolato gerarchico”, ma tutto il popolo di Dio. L’agire ecclesiale è il modo con cui il popolo di Dio si edifica, lasciandosi plasmare dalla Parola e dall’Eucaristica come corpo di Cristo, pane spezzato per noi e per tutti. Edificazione della comunità (comunione) e sua irradiazione nel mondo (missione) non sono che le due facce dell’unico cammino con cui gli uomini accedono a Cristo. Da qui derivano le due coordinate essenziali per comprendere il compito del presbitero: il rapporto alla comunità, perché sia il segno che rende presente il mistero di Cristo oggi; la relazione solidale con il presbiterio e con il Vescovo, anzi con l’intera Chiesa locale. Ecco ciò che sta lentamente emergendo: la figura del prete dovrà essere caratterizzata dalla “orizzontalità” e dalla “comunionalità”. È finito il tempo della parrocchia autosufficiente. È giunta al capolinea anche la figura del parroco isolato e monocratico! Egli resta necessario, ma non è più sufficiente. Il presbitero è l’uomo della comunione che presiede alla sinfonia dei carismi ecclesiali: ne cura il sorgere, ne custodisce la singolarità e la complementarità, ne promuove la piena espansione missionaria. Questo è il sogno dell’agire pastorale della Chiesa del Vaticano II: veder nascere persone che stanno in mezzo alla comunità come coloro che servono alla comunione. Così facendo il volto della parrocchia diventerà da se stesso missionario, perché sarà come il roveto ardente che porta a Dio. Da ciò deriva anche la forma e il modo della missione della Chiesa nel mondo, il nuovo stile della “pastorale”.
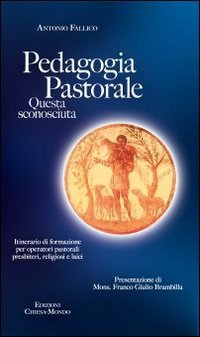
Non è un caso che l’opera che presento, di Antonio Fallico, alla sua seconda edizione rivista e aggiornata, nasce sull’asse Chiesa-mondo. Tra i molti scritti dal pastoralista catanese, questo è in qualche modo la summa del suo modo di intendere la missione ecclesiale. Essa è come il momento di autocoscienza della sua insonne passione di ripensare la pastorale nel legame tra Chiesa e Mondo (entrambi da scrivere, nella sensibilità dell’autore, in maiuscolo). Quest’opera andrebbe collocata sullo sfondo del suo progetto di fare della Chiesa locale, in particolare della parrocchia, una “comunione di comunità”.
Anche se, forse, altri scritti meglio di questo parlano più da vicino del suo progetto, attorno a cui ha suscitato anche una significativa convergenza di interessi e di persone. Infatti, la presente opera si pone già fin dalle prima battute a un livello di universalità, come si addice a un manuale che intende introdurre alla missione pastorale della chiesa. Un “manuale” deve evitare di essere troppo singolare, troppo legato a una prospettiva particolare, soprattutto se deve educare al sensus ecclesiae. Anzi, poiché si tratta di un manuale di teologia pastorale, esso deve educare all’actio ecclesiae, nel duplice senso del genitivo, cioè all’azione che fa la Chiesa (gen. oggettivo) e che è fatta dalla Chiesa (gen. soggettivo). La prima non va senza la seconda: il “fare” la Chiesa non è possibile senza un “lasciarsi fare” della Chiesa. Non si tratta di due tempi: prima la Chiesa si lascia fare, si lascia edificare e, poi, la chiesa edifica se stessa come segno vivo dell’accoglienza del vangelo per tutti gli uomini. Il suo “fare la Chiesa” è un “lasciarsi fare” dallo Spirito, il momento passivo è originario rispetto al momento attivo. Non sta prima o alle sue spalle, ma sta al centro e nel suo cuore. Ne è il centro propulsore permanente!
Per questo un manuale di “teologia pastorale” non è solo un testo di trasmissione di valori e di idee, neppure è solo un testo che abilita a progettare tattiche e strategie. È molto di più. Esso deve consegnare una sensibilità e uno stile: chiamo sensibilità una coscienza pratica, chiamo stile una prassi cosciente. Forse qui sta la questione critica della proposta di Fallico di un manuale di pedagogia pastorale. Egli cerca, nella vasta area della teologa pastorale, di accreditare lo spazio per una “pedagogia pastorale”. Un corso di tal fatta forse non si trova nella ratio studiorum proposta per l’abilitazione al ministero ecclesiale. Anche perché nonostante l’enfasi sulla pastorale nel postconcilio, l’anno di teologia pastorale (il cosiddetto sesto anno di teologia) è un’araba fenice: che ci debba essere ciascun lo dice, che si debba fare o come si faccia nessun lo sa. Se questo vale (si noti a quasi cinquant’anni dal fatidico inizio del Concilio) per il ministero dei pastori, a maggior ragione vale anche per la formazione ministeriale (ad intra e ad extra) dei laici. Perciò la proposta di Fallico si rivolge ad entrambe le figure, sul presupposto che la situazione attuale e quella del futuro prossimo esigono non solo ministri volonterosi, ma anche ministri competenti e preparati. La proposta si misura su due aspetti molto importanti: la rilevanza teorica e la declinazione pratica della formazione pastorale. La prima e la seconda parte sono dedicati alla fondazione metodologica del bisogno di una “pedagogia pastorale”, la terza e la quarta parte la declinano dentro un’architettura di notevole ampiezza.
Sull’aspetto teorico-fondativo vedo già la turba dei pastoralisti di professione addestrare le dita alla battaglia. Siccome non appartengo ai pastoralisti di professione, ma sono solo un simpatizzante prestato alla causa, qui dirò solo poche cose essenziali per dare un contributo alla pace. Dentro l’ampia regione del momento pratico della teologia (a cui appartengono molte materie di studio, come la liturgia, la morale, il diritto, ecc.), anche la teologia pastorale sta cercando faticosamente di darsi uno statuto teorico. Don Fallico stesso con molta probità nella seconda parte ne ripercorre la storia, e traccia il lento affermarsi di qualcosa come una teologia pastorale, citando in modo informato e competente i campioni della disciplina, sia i precursori storici, sia coloro che nel Novecento hanno rivendicato alla materia uno spazio disciplinare proprio. Nella definizione dello statuto della disciplina, l’autore fa professione di umiltà, si riferisce ai probati auctores europei (Arnold, Rahner) e italiani (Midali, Grolla, Lanza, Sartori, Seveso, ecc.) non discutendo in modo troppo sottile le loro differenze di sensibilità, ma facendoli convergere su una sorta di comun denominatore, che vede nella “pastorale” l’agire della chiesa e nel discernimento storico la forma specifica della sua attuazione. Allora la “teologia pastorale” sarebbe la riflessione critica sull’agire della chiesa e sulle forme della sua (auto)realizzazione. La pastorale starebbe alla teologia pastorale come l’arte alla scienza: l’agire pastorale della Chiesa nella sinfonia dei suoi ministeri e carismi è un’arte, la teologia pastorale è quella scienza che determina i metodi, i criteri e gli strumenti dell’atto con cui la Chiesa edifica se stessa nel tempo.
Il carattere “artistico” dell’agire ecclesiale va sottratto a un’interpretazione spontaneista o carismatica, come fosse una sorta di dono/abilità che appartiene a pochi; gli va restituito il carattere di sintesi pratica, cioè di intuizione valoriale e di atto di discernimento, superando una comprensione dicotomica dei due momenti, quasi che prima ci siano le dottrine e i tipi ideali, mentre la pratica pastorale non potrebbe che dedursi da una dottrina che abita l’iperuranio dei valori. Il carattere “scientifico” della teologia pastorale va compreso, di conseguenza, come atto secondo, come ri-flessione appunto: abbandona la sua pretesa direttiva di fornire quasi modelli preconfezionati all’agire ecclesiale; si rivela più fruttuoso se elabora criteri e strumenti per un’ermeneutica all’altezza dei tempi dell’azione pastorale nel vorticoso mutamento odierno. Per evitare i due estremi che stanno sotto gli occhi di tutti: una missione pastorale “cieca”, che pensa e vive il suo atto in modo “scriteriato” e pragmatico, quasi mettendo il carro del fare davanti ai buoi della guida sapiente; una riflessione pastorale “vuota” che si strema con interminabili discussioni sul funzionamento sociale dell’agire pastorale incapace di ascoltare la pulsazione viva del corpo ecclesiale nel mondo odierno. Detto in modo più accessibile: abbiamo pastori che sono abbandonati sul fronte della battaglia senza neppure il tempo di pregare, pensare, scegliere; vi sono pastoralisti (e teologi) che stanno nelle retrovie dorate dei convegni, che s’accaniscono a discutere della casa che brucia e a contare quanti secchi d’acqua necessitano per spegnere l’incendio. Occorre spezzare il circolo vizioso di una pastorale che fa e di una teologia che pensa; per introdurre il circolo virtuoso di una pastorale che è sapiente e di una teologia che la serve pensando.
È forse per questo che la proposta di Fallico si sporge sulla necessità di una pedagogia pastorale: cioè di un’attenzione alla saldatura dell’aspetto ermeneutico e dell’aspetto formativo della riflessione pastorale. Non so se la sua proposta riceverà il plauso dei pastoralisti. È facile immaginare l’obiezione del ritorno a una concezione “direttiva” della teologia, che elabora cioè modelli e strategie in vista della fruizione pratica e predispone sensibilità e percorsi per la sua appropriazione personale e comunitaria. Una difficoltà simile era stata avanzata anche nei confronti di un certo modo di intendere la teologia spirituale in rapporto al vissuto spirituale: che essa cioè avesse una pretesa in qualche modo pedagogica nei confronti dell’esperienza cristiana. Salvo osservare che nella storia della Chiesa non era così, perché solo i santi hanno insegnato a pregare, ma i veri maestri della preghiera non hanno mai disdegnato il confronto talvolta aspro e drammatico con i teologi (si pensi solo a Teresa d’Avila), perché i loro percorsi si lasciassero illuminare da criteri cristiani. Parimenti è stato per i grandi pastori e riformatori: non hanno atteso per riformare il volto della Chiesa una riflessione teologica compiuta o una strategia pastorale elaborata fuori dalla mischia, ma non l’hanno neppure trascurata confrontandosi con la migliore teologia di quel tempo. Se questo è il senso della proposta di Fallico si può anche consentire, perché la sua esperienza di parroco-pastoralista gli fa aprire lo spazio – in realtà si tratta di un’ampia regione – per l’appropriazione non solo del sensus ecclesialis, ma di una coscienza pratica pastorale. Che egli vede fortemente carente non solo sul fronte dei tanto invocati, quanto poco formati, ministeri laicali, ma anche nella nuova emergenza dei ministeri ordinati. La nuova stagione sembra ripresentare il ritorno di un sacro cultuale, senza nerbo per la sensibilità pastorale della vita quotidiana delle persone e per la dedizione al cambiamento del mondo.
A questa preoccupazione è dedicata la prima parte del manuale – persino abbondante e generosa – per rivisitare la storia della pedagogia moderna e contemporanea, che si salda con la seconda, per formulare all’inizio della terza in modo programmatico la proposta di una pedagogia pastorale. In questi termini: «da tempo sentiamo il bisogno di una vera e propria ars educandi nella non facile missione pastorale dei cristiani e delle comunità cristiane nel mondo, oltre che del presbitero-pastore in quanto tale» (p. 199). Per dirne in modo sintetico l’identità così: «occorre distinguere l’educazione pastorale dalla pedagogia pastorale e intendere la prima (educazione pastorale) come modo di venire educati e di educare cristianamente, e la seconda (pedagogia pastorale) come riflessione sulle modalità educative inerenti alle varieattività pastorali della Chiesa in servizio del mondo: attività già compiuteo ancora da compiere nell’oggi e nel qui della storia umana, alla luce della caritas pastoralis di Gesù buon pastore» (p. 200). E guadagnarne in tal modo lo statuto di scienza: «La pedagogia pastorale vuole essere una scienza e, sulla scia delle altre scienze teologiche – essendo fornita di oggetto proprio, fine proprio, metodi propri e criteri propri – si pone di conseguenza come la disciplina che studia le modalità di comportamento della comunità ecclesiale, e quindi dei cristiani, nell’impatto diretto col mondo, l’uomo e la sua storia. Conseguentemente analizza i rapporti e approfondisce i processi evolutivi, che tale incontro provoca nel convivere collaborare e camminare insieme: Chiesa e mondo, vangelo e vita, fedeltà a Dio e fedeltà all’uomo, vita sacramentale e servizio socio-politico, fede e impegno nel territorio» (p. 202). Si potrà discutere quanto questa definizione di pedagogia pastorale si scosti da quella di teologia pastorale, nella misura in cui quest’ultima tra i suoi compiti si fa carico anche dell’aspetto educativo. Ci si potrebbe attardare per molto tempo nel dibattito seguente: se la dimensione pedagogica sia trasversale alla teologia pastorale, quando essa non rifletta solo sulle leggi e sui criteri del funzionamento dell’agire storico della chiesa, ma si prenda a cuore anche i processi di appropriazione vitale della sensibilità ecclesiale e di abilitazione pastorale all’esercizio di un ministero. La vicenda dei ministeri pastorali nelle nazioni del nord Europa la dice lunga: la loro preparazione prevalentemente nel contesto della Facoltà di teologia nelle Università di Stato, ha preparato una schiera di professionisti e professorini della pastorale, ma con scarso senso ecclesiale e con debole coscienza spirituale. Il contesto ecclesiale della formazione è decisivo per sfuggire a questo pericolo, rimediando a quello opposto che è tipico dell’Italia di avere ministeri pastorali volenterosi e generosi, ma un po’ pressappochisti.
Di là dunque dalla diatriba se la pedagogia pastorale sia una disciplina regionalmente autonoma dalla teologia pastorale o una dimensione di questa, sta il fatto che nel manuale che abbiamo tra mano la parte più persuasiva è quella dedicata alla declinazione pratica dei compiti (Parte III: cap. V-XII), degli itinerari (Parte IV: cap. I-VI) e degli ambiti (Parte IV: cap. VII-XIX) della pedagogia pastorale. Praticamente l’enciclopedia di un percorso di pedagogia pastorale applicata. Non manca (quasi) niente, anche se la tendenza a fuggire il defectus elenchi può far sembrare l’ultima parte interminabile: più da consultare in ragione del bisogno, che da studiare come percorso compiuto di un manuale. Due cose però vorrei segnalare, che ci fanno approdare a una conclusione, che costituisce – forse – il motore segreto di quest’opera. La prima: merita certo una particolare attenzione, al limite del testo che sembra steso di getto e in presa diretta di fronte al lettore implicito, la panoramica che potremmo intitolare: Dio educa il suo popolo attraverso Gesù (Parte III: cap. IX-XII). Forse proprio qui si potrebbe parlare di una lettura sapienziale – di sapienza pastorale – della Bibbia, compreso un decalogo biblico per l’operatore pastorale. È scritta con una vera sensibilità educativa, che rivela un’autentica abilità dell’autore come accompagnatore pastorale. Come ci sono i padri spirituali, così vorremmo veder nascere in questo postconcilio anche maestri di pastorale! La seconda: la lunga declinazione dei luoghi attuali della pastorale sembra quasi seguire la traccia di un elenco che sta nella dialettica tra gli uffici (i tria munera) e gli ambiti (i cinque di Verona e oltre). Anche qui sarebbe interessante vedere la diversa e complementare funzione dello schema dei tria munera e di quello degli ambiti: il primo inteso ad articolare unità e diversità della missione della Chiesa; il secondo volto a dire la destinazione all’unità della persona e al suo compito formativo. L’amico fraterno che è don Antonio Fallico, che ha lungamente lavorato sui primi ha visto subito con entusiasmo l’opportunità dei secondi, aggiornandoli in questa seconda edizione (parte IV: cap. II). Perché con essi si raggiungeva l’intenzione profonda della sua pedagogia pastorale.
È forse qui che si svela il motore segreto della proposta di pedagogia pastorale di mons. Fallico. Egli è stato e continua ad essere sul campo un “maestro di pastorale”. Ma ha compreso che questo suo rapporto educativo nella formazione degli operatori ecclesiali e ai ministeri pastorali conteneva già un sapere credente, anzi una sapienza ecclesiale. L’ars educandi (quella volta all’educazione della coscienza e dell’identità della persona e quella indirizzata alla formazione dei formatori) contiene una sapienza che ha bisogno di essere portata alla parola. Per questo egli ha sentito l’impellente bisogno intellettuale e l’urgente passione ecclesiale (di cui si può trovare subito, nei Prolegomeni all’inizio del manuale,un ardente saggio) di dargli non solo una forma consapevole, ma anche una veste critica. Potremmo immaginare – e dite se è poco – che l’autore voglia scolpire nel suo testo quel lettore implicito che spera di trasformare in attore modello. Protagonista di un’azione corale e sinfonica: fare la Chiesa come segno vivo del vangelo accolto per la vita del mondo!
+ Franco Giulio Brambilla, Vescovo ausiliare di Milano












